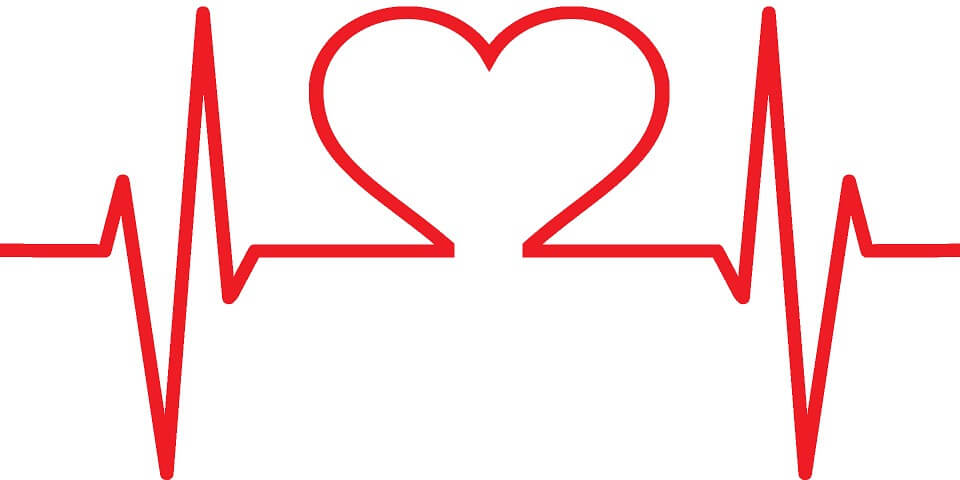E’ mercoledì, sono le 21.40 e sto tornando a casa dal servizio di volontariato in ospedale. Qualcuno potrebbe pensare che sia troppo tardi, che sia veramente assurdo uscire a quest’ora, ma vi dirò che questa attività non conosce tempo, al massimo ammette un po’ di stanchezza, ma prima di tutto, amore. Credetemi se vi dico che ogni volta che esco da quel posto ho il cuore colmo di speranza, credetemi se vi dico che, anche in mezzo a tutto quel dolore e rassegnazione, c’è una incredibile voglia di tornare a vivere nonostante le evidenti avversità. Io non sono né un medico né un’infermiera, non ho le qualifiche o le conoscenze per curare fisicamente queste persone, perché io li dentro sono semplicemente Maria Letizia, con indosso una maglietta blu, un cartellino e un sorriso. Percorrendo i corridoi dei vari reparti dell’Umberto I mi sento pervasa da strane sensazioni che mi spaesano un po’, ma mi sforzo di tenere i piedi ben saldi per terra, perché quello che sto facendo in quel momento ha un profondo e immenso valore.

Prima di approcciarmi al servizio vero e proprio ho affrontato un intenso corso di formazione, in cui ho appreso le basi per entrare nel dolore degli altri in punta di piedi, quasi impercettibilmente.
Dopo, si può anche far rumore, ma la prima cosa è avere rispetto, non dimenticarsi mai che chi si ha di fronte vive una condizione complessa, molto amara. Nessuno dei volontari ha la presunzione di rimettere insieme quelle persone, di fargli dimenticare la sofferenza- sarebbe impossibile – ma tutti abbiamo la volontà e il desiderio di strappargli un sorriso. Anche mezzo, accennato a malapena.
Mi accorgo spesso che, anche quando i pazienti non hanno voglia di chiacchierare, rimangono incuriositi dalla nostra presenza in quei lunghi corridoi in cui si mescolano antisettico, odori nauseabondi della cena e colori sbiaditi delle pareti. Così, quando loro ci osservano, noi facciamo capolino nelle loro stanze, chiediamo se hanno voglia di compagnia e poi aspettiamo una risposta. A volte ci rifiutano, sono scettici, non gli va di interagire e ci liquidano frettolosamente. Non tutti hanno voglia di esporsi e condividere, del resto la malattia è una condizione di fragilità estrema, non è sempre detto che debba per forza unire. Anzi, è più probabile imbattersi in pazienti maldisposti. Eppure, prima di mandarti via dicono sempre “grazie”.
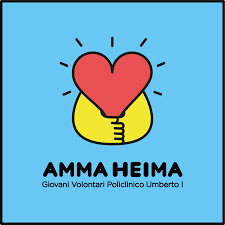
In quel momento, minuscolo e insignificante all’apparenza, sento di aver fatto la differenza. Sono entrata a far parte di “Amma Heima” da soli due mesi, ma ciò che mi sta insegnando questa incredibile esperienza va oltre un numero di settimane e giorni. Sono terribilmente grata alle persone che ho conosciuto e che mi seguono in questo percorso.
Quello che sto imparando dai miei colleghi, in questa nuova e bellissima famiglia, è che stare a contatto con i pazienti è difficile, estenuante, perché corriamo il rischio di farci annichilire dal loro dolore, ci vestiamo di esso, ci sentiamo in colpa per loro. Siamo piccoli e impotenti, e succede che le emozioni negative prendano il sopravvento. Vorrei potervi dire che il servizio in ospedale è sempre bello e gratificante, positivo e sereno, però non posso farlo, non sarebbe vero.
L’abbattimento, il burn out, sono sempre dietro l’angolo. Siamo esseri umani, per questo non invincibili e sempre esposti a rischio. Eppure, ne vale la pena.
Se ripenso al sorriso sereno di Pierina, alla faccia buffa di Incoronata, a Teresa, a Carola e a tutte le persone che occupano quei lettini, sento che ogni volta, ho qualcosa da tenermi stretto dentro, cucito nel cuore. Allora conto ogni passo, ogni centimetro percorso nel Policlinico, centellinando ogni angolo, tenendo sempre presente di star facendo qualcosa per gli altri e anche per me. Mi sono sentita dire spesso che il volontariato vero e disinteressato non esiste, ci si avvicina ad esso con la pretesa egoistica di colmare un vuoto nostro, e magari è così, certo. Però si prova a farlo costruendo qualcosa, insieme agli altri e per gli altri, per questo non bisogna sminuirne il valore.
“Prezioso” e “grazie” sono le parole che sento pronunciare più spesso dai pazienti e durante le supervisioni a fine servizio. Perché è prezioso, fondamentale, sentire le storie degli altri, per capire, confrontarsi e partecipare; è, d’altro canto, necessario, vitale, sentirsi dire grazie, perché non è così scontato. Fare del bene, come amare, è qualcosa che si dovrebbe imparare a fare senza aspettarsi nulla in cambio. E’ vero che nessun gesto è totalmente disinteressato, ma quando, lentamente, si inizia ad accettare di essere in grado di dare senza per forza ricevere qualcosa di ritorno, forse è lì che nasce l’amore.
Sapete, io di fronte a tutto questo mi sento piccola, ancora una millesima parte di un macrocosmo immenso. Non conosco ancora i percorsi da un reparto ad un altro, mi perdo negli ascensori e nei sotterranei, ma c’è sempre una luce. È forse troppo presto per parlarvi di altro, ma quello che so per certo ora è che fare questo tipo di attività ti cambia.
Ti trasforma lentamente, anche se non te ne accorgi. Fare del bene fa bene, ed è giusto non dimenticarsene.
Per questo posso dirvi che il volontariato ospedaliero è difficile e complesso, bisogna cercare di non perdere di vista gli altri e prima ancora sé stessi. Ma è anche vero che, per quanto possa apparire un cammino in salita, ci sarà sempre qualcuno pronto a tenderti la mano, e ciò che è stupendo è che a volte sono i pazienti la nostra cura. A volte sono proprio loro il rimedio alla nostra tristezza o smarrimento, sono loro ad insegnarci e guidarci, a ricordarci perché stare al mondo.
Ed è questo che provo a fare ogni settimana, seminare del bene laddove posso e riesco, e aspetto che nasca qualcosa. Alla fine, che sia una delusione o una debolezza, un fiore o una speranza, realizzo che, in qualche modo, si può sempre rinascere.
Nata a Cosenza nel 1994, vive da sette anni a Roma. Laureata in Filologia Moderna, attualmente tenta di rendere produttiva la sua laurea seguendo un Master e facendo tutti i lavori possibili.
Ama la musica, viaggiare, la vita la coinvolge totalmente e vorrebbe scoprire il mondo.
La sua passione più longeva è sicuramente la lettura, il primo libro che ha letto è “Giovanna nel Medioevo” e ha pianto senza ritegno dopo aver terminato “La piccola Principessa”.
Incapace e negata per ogni tipo di sport (ma è fiera di aver praticato basket per una settimana), ama correre con le cuffie nelle orecchie e camminare per tutta Roma.
Il suo gruppo preferito sono gli Oasis, e mentre spera che tornino insieme, immagina sempre come sarebbe la sua vita se la smettesse di sognare ad occhi aperti.